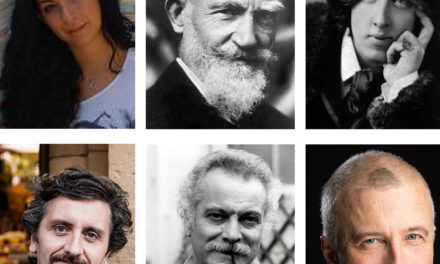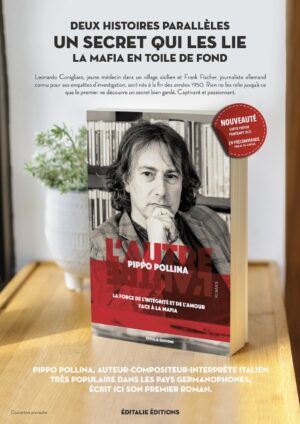Abbiamo incontrato il giudice Leonardo Guarnotta membro del pool antimafia all’occasione della pubblicazione in Italia del suo libro C’era una volta il pool antimafia (Zolfo editore). Ci siamo lasciati guidare dentro la Palermo dei misteri. Non è solo racconto e testimonianza, ma anche documento, cronaca degli avvenimenti dall’inizio della creazione del famoso pool antimafia con Falcone e Borsellino, fino al Maxiprocesso e all’estate dolorosa del 1992.
Intervista raccolta da Rocco Femia.
A leggere il libro lei non si sentiva la vocazione dell’eroe e sapeva perfettamente a cosa andava incontro un giudice che si fosse occupato di mafia in quel periodo a Palermo.
Sin da piccolo sognavo di diventare un magistrato, di indossare quella lunga sopravveste nera che si chiama toga, di rendere un servizio ai cittadini rispondendo alle loro domande di giustizia in tempi celeri. L’essere entrato a far parte del pool antimafia non ha mutato la mia interpretazione della “normalità” del “ruolo” che ricoprivo, anche se mi rendevo conto dell’importanza sul piano sociale e della pericolosità del nostro lavoro, che mirava a restituire la Sicilia, ferita e oppressa dalla mafia, ai siciliani onesti.
Due elementi sono stati importanti secondo lei per combattere seriamente la mafia.
Una costante partecipazione a dibattiti, convegni e incontri con gli studenti, coinvolgere scuole, società civile, associazioni, perché alla fine prevalesse la cultura della legalità. La seconda intuizione è stata quella di considerare la mafia un’organizzazione verticistica e unitaria. Non una congrega di bande in perenne competizione fra loro, ma un’organizzazione che potremmo definire “federale” e dotata di una certa unità.
Il Consigliere Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, è stato il primo magistrato ad uscire dal Palazzo di Giustizia per incontrare i giovani ai quali spiegare che cosa era Cosa nostra, problema endemico della Sicilia, affinché ne percepissero la pericolosità, nella convinzione che la sola repressione, ad opera delle forze dell’ordine e della magistratura, non fosse sufficiente ad arginare quel deleterio fenomeno criminoso. Occorreva, quindi, coinvolgere gli studenti, la scuola, le università, in un’opera di recupero della cultura della legalità, del rispetto della legge di ossequio al dettato normativo.
Ma Rocco Chinnici ebbe anche l’idea geniale di considerare Cosa nostra una struttura verticistica ed unitaria, non un insieme disorganico di bande dedite a traffici illeciti e magari in continua lotta tra loro.
Occorreva, allora, costituire un gruppo di magistrati che si occupassero delle stesse indagini, coeso e teso al conseguimento di un comune risultato sino a quel momento mai raggiunto.
Nasce così il pool antimafia, piccolo avamposto in un territorio pericoloso in cui, ogni giorno, si combatteva una guerra mai ufficialmente dichiarata dallo stato italiano ma combattuta sino alla fine.
Cosa ricorda della strategia del follow the money, seguire il denaro e le transazioni per arrivare a smascherare i colpevoli. Questo perché la mafia era già cambiata agli inizi del 1980?
Istruendo il processo a carico di Rosario Spatola, un costruttore e faccendiere siciliano, su cui gravava l’accusa di gestire, insieme a suoi sodali, un grosso traffico di droga tra la Sicilia e gli U.S.A., Giovanni Falcone comprese che era riduttivo e fuorviante indagare solo a Palermo, in Sicilia ed in Italia – perché la mafia era anche un fenomeno criminale transnazionale – che la sua potenza economica aveva superato i confini della Sicilia e che era necessario penetrare nei “santuari” degli istituti di credito, dovunque si trovassero, perché proprio lì affluivano e venivano “lavati” gli ingentissimi proventi accumulati con i traffici internazionali di droga.
Nasce così il metodo Falcone: “follow the money”, segui il denaro, nella consapevolezza che, se la droga non lascia quasi tracce, il denaro ricavato dal suo commercio non può non lasciare dietro di sé una scia, dei segni, delle orme del suo percorso, del suo passaggio da chi la fornisce a chi l’acquista.
Uomini e metodo del pool
Qual è il ricordo più bello di Antonino Caponnetto, la guida del pool antimafia?
Il consigliere Antonino Caponnetto è stata la nostra guida, il nostro padre putativo, il sapiente coordinatore di un pugno di giudici istruttori che in lui faceva sicuro ed assoluto affidamento e che in lui trovava conforto ed incoraggiamento nei non infrequenti momenti di difficoltà.
Conservo nella memoria una delle sue frasi più belle e cariche di significato:
“Ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare, di agire da uomini liberi e consapevoli. State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi stessi!
L’avvenire è nelle vostre mani.
Ricordatelo sempre!”
Mi piacerebbe che queste parole fossero il testamento morale di “nonno Nino”, come veniva chiamato dai giovani che incontrava nella scuole.

Quale il suo ricordo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino?
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano soltanto due giudici ma due grandi giudici e due grandi uomini, le cui doti di professionalità, di intuito giuridico, di preparazione, di assoluta dedizione alla causa, di senso dello Stato e di spirito di servizio costituiscono, ormai, patrimonio conoscitivo di tutti noi.
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non appartengono soltanto alla storia del nostro paese ma sono ancora presenti tra noi e lo saranno a lungo perché la loro speranza in un domani migliore e il loro coraggio sono la stessa speranza e lo stesso coraggio ereditati e fatti propri da tutti coloro che li hanno amati, condividendo quei valori ai quali Falcone e Borsellino hanno improntato il loro lavoro quotidiano e recependo il loro insegnamento di fare sempre il proprio dovere, la propria parte senza fermarsi mai davanti agli ostacoli, alle incomprensioni ed alle avversità con le quali inevitabilmente ciascuno di noi si imbatterà nel proprio cammino, perché proprio in questo risiedono la dignità e la moralità umane.
È un puro caso oppure occuparsi seriamente e con tutto sé stesso di mafia in Italia non è un buon viatico per fare una prestigiosa carriera in magistratura?
Giovanni Falcone ha condotto la sua battaglia contro la mafia sino al sacrificio supremo della vita, ma non gli sono state risparmiate delusioni, ferite, sconfitte. È stato il magistrato più bravo d’Italia ma anche il più ferito. Una sorta di Aureliano Buendía con la toga, il colonnello dei Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez che condusse trentadue battaglie e amaramente tutte le perse.
Gli venne preferito Antonino Meli quando si candidò a guidare il pool dopo Antonino Caponnetto. Un mese dopo, fallì anche la nomina alla guida dell’Alto commissariato per la lotta alla mafia perché gli preferirono Domenico Sica; si candidò alle elezioni dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura del 1990 e non venne eletto. Per la Procura Nazionale antimafia gli venne preferito Agostino Cordova. Occuparsi seriamente e con tutto se stesso di mafia in Italia, nonostante molti lo sostengano, non è proprio un buon viatico per fare una prestigiosa carriera in magistratura. Tranne qualche rara eccezione.
Sarà un caso ma a nessuno di noi, a nessun altro del pool, è capitato. Non siamo diventati delle star, né volevamo esserlo del resto, e non ci avete visto spesso in tv. Forse anche questo faceva parte del marchio di fabbrica del pool antimafia.
La stagione dei pentiti
Parliamo dei pentiti di mafia. Senza di loro, forse, non sareste riusciti a conseguire i risultati che avete raggiunto. E poi, forse, perché alcuni mafiosi compresero che lo Stato stava facendo sul serio nella lotta alla mafia.
Prima della collaborazione di Tommaso Buscetta non si aveva ancora un’idea precisa di come fosse organizzata Cosa nostra. C’era quasi la contezza della sua esistenza da notizie che risalgono alla notte dei tempi, ma le regole interne, i rapporti tra gli “uomini d’onore”, le gerarchie non erano del tutto noti. Come constatò Falcone, “prima di lui, non avevo ‒ non avevamo ‒ che un’idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare coi gesti”.
Grazie al “professore di lingue” e alle complesse indagini effettuate dal pool, appena costituito, è stato invece possibile indagare, finalmente, a fondo: i numerosi, efferati omicidi, il traffico di sostanze stupefacenti e di armi, i sequestri di persona, le rapine. E poi le estorsioni consistenti nell’imposizione del “pizzo”, cioè il pagamento di somme di denaro, a commercianti, imprenditori e professionisti, le cui attività si svolgevano nel territorio sotto la giurisdizione delle numerose “famiglie” mafiose operanti a Palermo e Provincia.
Le indagini hanno consentito, soprattutto, di far luce sulla guerra di mafia combattuta tra il 1981 e il 1983, nel corso della quale vennero uccisi, a opera dei “picciotti” di Riina e Provenzano, uomini d’onore della fazione avversa quali Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. Allora, fu consumata una vera e propria mattanza, una chirurgica resa dei conti che insanguinò la città di Palermo in nome del predominio egemonico di un clan, quello dei “Corleonesi”.
Buscetta e poi gli altri collaboratori di giustizia non spuntarono fuori per un caso fortuito, ma perché compresero che, stavolta, lo Stato faceva sul serio, al contrario di quanto avvenuto in passato. E, soprattutto, erano scesi in campo magistrati credibili come Rocco Chinnici, Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che avevano dimostrato con il loro quotidiano impegno di voler perseguire con forza Cosa nostra, incuranti dei pericoli ai quali sicuramente sarebbero andati incontro. Ed è altresì da riconoscere che un apporto decisivo nel contrasto al crimine organizzato di stampo mafioso è venuto dalla collaborazione di “uomini d’onore” attendibili, passati dalla parte dello Stato.
Tommaso Buscetta è stato, senz’altro, il collaboratore per noi più importante perché ha svelato, con dovizia di riferimenti sempre riscontrati, i segreti di Cosa nostra nei cui “valori”, non più quelli di una volta, non credeva più perché ormai era diventata una comune organizzazione criminale. In particolare, sin dal primo interrogatorio ha dichiarato, e lo ha poi sempre ribadito: “Non sono un pentito. Non sono una spia né un informatore, né un criminale che prova piacere a infrangere le leggi e sfruttare gli altri”. Nell’appunto che consegnò a Falcone il giorno del loro primo incontro c’era scritto: “Sono stato un mafioso e ho commesso degli errori per i quali sono pronto a pagare integralmente il mio debito con la giustizia senza pretendere sconti né abbuoni di qualsiasi tipo (allora la legge sui pentiti non esisteva ancora, ndr). Invece, nell’interesse della società, dei miei figli e dei giovani, intendo rivelare tutto quanto è a mia conoscenza su quel cancro che è la mafia affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano”.
Parole impegnative di un mafioso che aveva uno spessore criminale importante e che, nonostante non avesse mai assunto ruoli apicali in Cosa nostra, godeva di grande rispetto nell’ambito dell’organizzazione.
La storia racconterà che Buscetta ebbe totale fiducia in Giovanni Falcone, non nello Stato. Ma in realtà quel giudice istruttore faceva parte, con gli altri uomini del pool, di una componente, sia pure minoritaria, delle istituzioni che voleva vederci chiaro sul perverso intreccio politico-mafioso-imprenditoriale, perché non tutto era stato ed era sempre e soltanto mafia.
Quando il clima cambia
Nel corso del Maxiprocesso, fuori dall’aula bunker, si registrò un fatto che scosse Palermo. In un articolo di Leonardo Sciascia dal titolo “I professionisti dell’antimafia” pubblicato dal “Corriere della Sera” il 10 gennaio 1987, l’autore del libro Il giorno della civetta, un libro utile per comprendere cosa sia la mafia, improvvisamente ve lo siete trovato contro, dall’altra parte della barricata. Come mai?
La sentenza della Corte di Assise ci aveva dato ragione ma tutto era ancora in gioco. La tappa successiva sarebbe stata il processo di appello avverso “quella” sentenza, troppo “pericolosa” per Cosa nostra, che aveva segnato una svolta epocale nell’azione di contrasto alla mafia.
Avevamo oltrepassato la linea rossa e la reazione non tardò a farsi sentire.
Ma non si ricorse a una reazione con bombe, versamento di sangue, omicidi. La strategia scelta fu molto più sottile, lucida, non usuale, quasi raffinata. E per portarla a compimento furono scelte persone in buona fede, che non si rendevano conto di diventare uno strumento per il conseguimento di obiettivi inconfessabili.
Era già cominciato tutto prima, mentre il maxiprocesso si stava celebrando.
In quel clima rientra il caso dell’articolo di Leonardo Sciascia, apparso nel gennaio 1987, a firma di quello che era lo scrittore più importante espresso dalla Sicilia negli ultimi cinquant’anni. Ancora oggi bisogna leggere il suo romanzo Il giorno della civetta per iniziare a comprendere, da profani, cosa sia la mafia. Il suo lavoro è sempre stato accompagnato da un forte impegno civile e da un’attenzione particolare nei confronti dei problemi della giustizia. Uomo attento alle regole, Sciascia era un garantista, un intellettuale che aveva molto a cuore i diritti e le libertà dei cittadini.
Noi in quegli anni cercammo di muoverci in quel solco, ma evidentemente non è bastato perché improvvisamente Sciascia ce lo trovammo contro, dall’altra parte della barricata. Forse mal consigliato – questa è la mia impressione – l’intellettuale siciliano diventò uno degli strumenti per attaccare il pool, in particolare Paolo Borsellino e, tramite lui, Giovanni Falcone. Il 10 gennaio 1987, alcuni magistrati si incontrarono con Sciascia in una galleria d’arte di Palermo, la Tavolozza, e gli consegnarono copia della delibera con la quale il C.S.M. nominava Borsellino procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, preferendolo ad altro candidato con maggiore anzianità di servizio, in violazione dell’intoccabile criterio “anzianità senza demerito”.
Il “Corriere della Sera” pubblicò con il titolo, “I professionisti dell’antimafia”, l’articolo che criticava la nomina di Paolo proprio a causa del mancato rispetto del criterio dell’anzianità. Eravamo ancora lontani dal constatare sulla nostra pelle, come poi è accaduto, il danno che avrebbe potuto provocare il pedissequo rispetto senza eccezioni di quel criterio… Ma questa constatazione, a mio parere, non giustifica l’intellettuale che, prendendo spunto dalla pubblicazione di un libro sulla mafia e il fascismo, scrisse: “I lettori, comunque, prendano atto che nulla vale più, in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso”.
Ed ancora, per rendere meglio il concetto, Sciascia accusò apertamente Paolo Borsellino di essere l’esempio di “una categoria di privilegiati che stava prendendo piede in Sicilia dove il potere fondato sulla lotta alla mafia è molto simile, tutto sommato, al potere mafioso e al potere fascista”.
Quell’articolo ebbe il grave demerito di fornire un’arma culturale e ideologica a chi avesse voluto attaccare in maniera apparentemente inoffensiva il pool e il lavoro che si stava facendo.
Sciascia forse non comprese di essere stato strumentalizzato dalla parte più conservatrice della magistratura, quella secondo la quale la carriera di un magistrato doveva procedere nel solco “dell’invecchiare e non demeritare”, mentre Falcone stava scardinando dalle fondamenta un mondo ormai vecchio per porre il merito, la conoscenza e le capacità al primo posto. Era la stessa magistratura convinta che all’Ufficio di Istruzione dovessero essere assegnati quei magistrati ritenuti non validi per i collegi giudicanti, ai quali soltanto dovevano essere assegnati i veri cultori del diritto. Era una lotta del vecchio contro il nuovo. E il nuovo perse.
Probabilmente Sciascia non fu pienamente consapevole, sul momento, dell’effetto devastante di quell’articolo, della cui origine mi sono sempre chiesto le ragioni. Forse l’obiettivo non era Paolo, il suo caso forniva soltanto lo spunto, ma l’articolo era un pretesto per attaccare anche Giovanni Falcone.
La fine del pool
Perché si volle sbarrare la strada a Giovanni Falcone? Qual era il disegno nascosto e chi c’era dietro secondo lei? Borsellino ebbe a dire in un’intervista che “Lo Stato si è arreso: del pool antimafia sono rimaste macerie”. Poi è successo quello che tutti sappiamo.
I cinquanta fogli del verbale della seduta del Consiglio Superiore della Magistratura nella quale fu decisa la bocciatura di Giovanni Falcone rappresentano una delle pagine più nere della magistratura italiana, un apologo del tradimento.
Ancora oggi leggendo i verbali della riunione del Plenum del C.S.M. in cui si decise la nomina di Meli è difficile non provare sgomento, sorpresa, delusione.
Ricordo a memoria: “accentrare il tutto in figure: emblematiche pur nobilissime è di certo fuorviante e pericoloso… c’è un distorto protagonismo giudiziario… si trasmoda nel mito”.
Cioè, con la eventuale nomina di Falcone non si sarebbe incoraggiata la vincente strategia di contrasto alla mafia ma, invece, si sarebbe corso il serio rischio di farne un protagonista, di creare un mito!
E ancora, un altro consigliere si esibì in un capolavoro di “architettura” argomentativa conclusa così: “Le notorie doti di Falcone e i rapporti personali e professionali mi indurrebbero a sceglierlo ma mi è di ostacolo la personalità di Meli cui l’altissimo e silenzioso senso del dovere costò la deportazione nei campi nazisti, con sofferenza e umiltà esprimo questo voto”.
La tragedia e la sofferenza umana di Meli strumentalmente utilizzate per frenare la corsa di Falcone.
Infine: “Se votiamo Falcone oggi, finisce che tra dieci anni ce lo troviamo presidente di Cassazione”, aggiunse qualcuno. Questo era il pericolo: che Giovanni potesse fare carriera. L’obiettivo non era dunque quello di scegliere l’uomo migliore per combattere la mafia, l’obiettivo era mettere fuori gioco Giovanni Falcone individuando prima e sostenendo poi un altro candidato, il quale potesse, almeno formalmente, giustificare una scelta del C.S.M., diversa da quella rappresentata da Giovanni Falcone, che fu sostenuta a tutti i livelli possibili e fu fatta propria da una ben individuata “alleanza trasversale e non solo giudiziaria”, che trovò l’indispensabile supporto operativo in una anomala composita maggioranza del C.S.M.
Non si trattava solo della sconfitta di un uomo. La percezione, quello che noi avvertimmo in quel momento, fu che qualcuno avesse deciso che era ora di finirla con il pool.
Avete vinto, vi siete “regalati” il maxiprocesso, ma la corsa termina qui.
E per sempre.
Dunque era proprio questo il disegno nascosto per sbarrare la strada a Giovanni Falcone ma la domanda “chi c’era dietro?” attende ancora una risposta definitiva.
L’estate delle stragi
E poi arriviamo alle stragi del 23 maggio e 19 luglio 1992 che vedono la morte rispettivamente di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E quella frase di Borsellino “ho visto la mafia in faccia”, al ritorno di un incontro con il ministro dell’Interno Mancino, il quale non ricordò mai di avere incontrato Borsellino. Oppure la frase che il giudice rivolse alla moglie al ritorno da Roma “Se mi succede qualcosa non sarà solo mafia”. Frasi terribili che sono ancora oggi il nodo più grave da sciogliere. Se non era solo mafia cos’altro è stato, giudice Guarnotta?
La frase “ho visto la mafia in faccia”, l’incontro con il ministro dell’Interno Mancino, incerto se ricordare di avere incontrato Paolo o no, la frase rivolta alla moglie “Se mi succede qualcosa non sarà solo mafia”. Tappe di un percorso doloroso con una fine annunciata, una disperata corsa contro il tempo, in quei terribili giorni della sua ultima estate, per scoprire i nomi degli esecutori materiali ma anche dei mandanti della strage di Capaci. Con la consapevolezza che bisognava fare in fretta, sempre più in fretta, perché era certo che il tempo stava per scadere anche per lui.
Paolo aveva capito, anzi aveva appreso, ma non da chi avrebbe avuto l’obbligo di informarlo, che il tritolo per lui era già pronto. Per questo consapevolmente si è allontanato dai suoi figli, perché soffrissero meno il momento del distacco.
La sentenza di primo grado del processo mediaticamente inteso “trattativa Stato-mafia” ha condannato a pene severissime rappresentanti delle istituzioni, politici, mafiosi, imputati di gravissimi reati forse commessi, anche ed in certo qual modo, per assicurare la sopravvivenza della mafia stessa.
A conferma che se Cosa nostra esiste da oltre centocinquanta anni la spiegazione sta tutta nella considerazione che ha trovato in una parte del potere politico le necessarie connivenze e protezioni.
Cosa fare, quale strategia adottare per avere definitivamente la meglio sulla mafia che costituisce da troppo tempo il problema endemico non più della Sicilia, ma ormai di altre regioni del Paese?
L’azione di contrasto a Cosa nostra non può essere opera soltanto della magistratura e delle forze di polizia, ma deve essere frutto di un condiviso, concorde e solidale impegno di tutte le componenti sane della società civile. La sola repressione, anche se ha consentito di conseguire risultati mai raggiunti prima, si è dimostrata insufficiente. E anche la necessaria opera di prevenzione, attuata attraverso un’azione di bonifica sociale, morale e culturale, sembra mostrare la corda e ha urgente bisogno dell’intensificarsi di un movimento antimafia che, agendo a tutto campo, sia in grado di coinvolgere le parti sane della società facendo loro comprendere che convivere con la mafia non è conveniente, contrariamente a quanto incautamente affermato, qualche tempo fa, da un ministro della Repubblica, che la mafia non produce sviluppo, quello sviluppo che può soddisfare i bisogni di tutti, che la lotta per la democrazia e contro la mafia va sostenuta a ogni costo da tutta la società civile. E allora è assolutamente necessario e indefettibile che coloro i quali hanno responsabilità istituzionali debbano seriamente impegnarsi per una pubblica amministrazione più efficiente e a prova di corruzione, per una politica più responsabile, più vicina e più attenta ai bisogni dei cittadini, per una giustizia più celere e credibile, per una imprenditoria più sana, per un sistema delle banche e delle professioni più trasparente.
Rocco Femia, éditeur et journaliste, a fait des études de droit en Italie puis s’est installé en France où il vit depuis 30 ans.
En 2002 a fondé le magazine RADICI qui continue de diriger.
Il a à son actif plusieurs publications et de nombreuses collaborations avec des journaux italiens et français.
Livres écrits : A cœur ouvert (1994 Nouvelle Cité éditions) Cette Italie qui m'en chante (collectif - 2005 EDITALIE ) Au cœur des racines et des hommes (collectif - 2007 EDITALIE). ITALIENS 150 ans d'émigration en France et ailleurs - 2011 EDITALIE). ITALIENS, quand les émigrés c'était nous (collectif 2013 - Mediabook livre+CD).
Il est aussi producteur de nombreux spectacles de musiques et de théâtre.