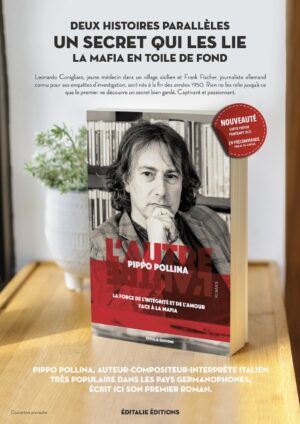L’ amministrazione papalina era tra le più clientelari ed elefantiache tra gli Stati preunitari. E tale rimase quando Roma divenne capitale del Regno d’Italia.
Il ragazzo dall’aria gracile e goffa che trotterella per le vie del centro di Roma, ha poco più di vent’anni e viene dalla provincia. Alloggia in una soffitta, a casa di parenti ricchi ma taccagni. È arrivato nella Città Eterna inseguendo un miraggio comune a tanti: conquistarsi il posto fisso in un’amministrazione pubblica. Insomma diventare un tranquillo funzionario. Lo stipendio è modesto, ma i placidi ritmi dell’impiegato statale gli lascerebbero tempo per la passione di sempre: la scrittura. Chi fa questi ragionamenti nell’inverno del 1822, camminando nel cuore del regno temporale di papa Pio VII, è un certo Giacomo Leopardi. L’illustre scrittore italiano è, infatti, in fuga dal “natìo borgo selvaggio” di Recanati (allora territorio pontificio). Il poeta spera che l’ambasciatore prussiano Nieburh, suo estimatore, interceda presso il cardinale segretario di Stato Ercole Consalvi, per procurargli la sospirata “cadrega” nella Cancelleria del Censo, l’archivio del catasto. Resterà deluso, perché l’anno dopo, la morte di papa Pio VII archivierà la pratica. Ma non bisogna essere troppo duri con lui: l’istanza di Leopardi era perfettamente coerente con il “sistema” in vigore nel regno teocratico e in particolare nella sua immensa, inefficiente e spesso contraddittoria burocrazia. Un groviglio che alla caduta dello Stato Pontificio e con l’irruzione dei Savoia a Roma, pochi decenni più tardi, si sarebbe solo in parte riuscito a dipanare.