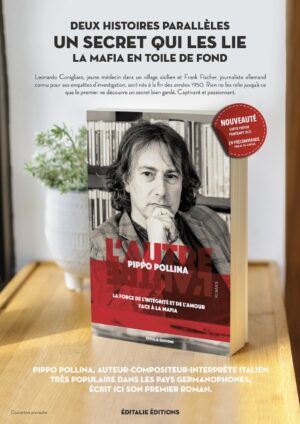Il fenomeno del brigantaggio è un pezzo di storia italiana che vale sempre la pena ricordare. “La guerra dei briganti” cominciò subito dopo l’Unità d’Italia, ed è sottoposta da tempo ad una domanda storiografica: fu criminalità o resistenza filoborbonica?
GIGI DI FIORE E MATTEO LIBERTI / FS
Le prime rivolte esplosero in Abruzzo già nel novembre del 1860, quando a Gaeta c’erano ancora il re Francesco II di Borbone con la moglie Maria Sofia, assediati dalle truppe piemontesi. Quel Sud, da poco diventato italiano, fu subito una brutta gatta da pelare per il governo di Torino. La ribellione contadina non era stata prevista e così le bande in armi divennero la principale spina nel fianco della sbrigativa, almeno per alcuni, unificazione. Il primo governo italiano, presieduto da Cavour, si rese conto ben presto di avere sottovalutato le difficoltà della realtà meridionale. C’era stato troppo ottimismo sulla possibilità di « normalizzare » quelle terre, confidando nell’atteggiamento benevolo delle masse contadine meridionali che invece si sentivano estranee a un’unità calata dall’alto. Le sommosse abruzzesi furono definite subito « episodi di brigantaggio ». In realtà erano azioni militari di corpi irregolari di soldati borbonici che avevano ricevuto il via libera da Francesco II di Borbone per compiere azioni di disturbo alle spalle delle truppe piemontesi impegnate nei pressi di Gaeta. La composizione di quei gruppi era flessibile: oltre agli ex soldati borbonici, c’erano anche civili e contadini. A gestire le prime repressioni, già nel dicembre del 1860, fu il generale piemontese Enrico Morozzo della Rocca, diventato comandante dell’esercito nel Mezzogiorno. Ricordò nelle sue memorie: « La reazione alzava la testa, le bande armate che infestavano le campagne s’ingrossavano di tutti i malcontenti e dei disoccupati che, condotti da qualche ufficiale borbonico, o da qualche altro poco accetto nell’esercito garibaldino, scorrazzavano sulle frontiere e anche nelle province napoletane« . E si era solo agli inizi.
SOLO CRIMINALI?
Quando i Borbone si arresero a Gaeta nel febbraio 1861, lasciando il regno e fuggendo per l’esilio romano, la situazione precipitò. Fu subito ribellione violenta. Il cocktail di uomini, e a volte anche di donne, che confluì in centinaia di bande era costituito da contadini, che avevano creduto nelle promesse di Giuseppe Garibaldi sulla redistribuzione delle terre e sull’uso dei terreni incolti demaniali, di cui latifondisti e notabili meridionali fecero invece man bassa. Queste bande erano composte anche da ex ufficiali e militari borbonici umiliati e trattati come traditori al loro ritorno a casa ed anche da qualche deluso garibaldino e da sbandati di ogni genere.
Per anni, gli storici hanno sostenuto che quella guerra civile fosse solo un problema criminale da reprimere, provocato da « briganti » assassini. E fu « briganti », il termine che bollò gli uomini in rivolta, ripreso da quel brigands che i francesi avevano coniato nel decennio 1806-1815 per definire chi si ribellava al loro dominio nel Mezzogiorno d’Italia. Attraverso la pubblicazione dei documenti scoperti dallo storico Franco Molfese negli archivi parlamentari, si dimostrò che c’era stato anche altro e di più. Lo scrittore Carlo Levi definì il brigantaggio post-unitario la « quarta guerra nazionale dei contadini del Sud, in cui l’umile Italia storicamente aveva torto e doveva perdere« . Antonio Gramsci sostenne che le masse contadine, assenti nella rivoluzione (elitaria) del Risorgimento, si batterono contro il nuovo Stato che sosteneva gli interessi di notabili e latifondisti nel Mezzogiorno. Ecco quanto scrisse nel 1920: « Lo Stato italiano ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrittori salariati tentarono di infamare con il marchio di briganti«
I RISVOLTI POLITICI
La situazione si complicò con lo scioglimento dell’esercito meridionale di Garibaldi, che regalò nuovi scontenti alla guerra contro quell’Italia voluta dai vincitori della destra liberale di Cavour. Poi ci si mise anche il servizio militare obbligatorio promosso dal re Vittorio Emanuele II in un Sud dove l’arruolamento non era mai stato regolato da norme rigide come in Piemonte. I recalcitranti si moltiplicarono e si diedero alla macchia. Divennero così « briganti ». L’incendio si propagò in Basilicata, Puglia, Calabria, Ciociaria al confine con lo Stato Pontificio e a parte della Campania che furono le zone dove le bande si fecero più agguerrite e pericolose. Nel 1861, le campagne meridionali divennero un vulcano ardente. Le cifre furono davvero da guerra: 39 bande in Abruzzo, 42 al confine con lo Stato Pontificio, 15 nel Molise e nel Sannio, 47 tra l’Irpinia e le province di Salerno, 47 in Basilicata, 34 in Puglia, 33 in Calabria e 6 in provincia di Napoli. Ogni capobanda aveva una sua storia di ingiustizie da vendicare, di rivalse da far valere. C’entravano, certo, la fame, l’assenza di prospettive di vita nel nuovo Stato, il bisogno di terra, la lontananza ideale da quel nuovo Stato italiano, i timori del servizio militare. Ma, in una realtà sociale ed economica incandescente, si inserirono anche gli emissari dei comitati borbonici sparsi ovunque, appoggiati dalla corte di Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie in esilio.
Il brigantaggio, soprattutto tra il 1861 e il 1863, fu così non solo guerra contadina di natura socio-economica, ma anche resistenza politica al nuovo regno italiano. Lo conferma la vicenda della Basilicata, dove agiva la banda di Carmine Donatelli Crocco di Rionero, ribelle che nelle sue memorie, dettate nel carcere di Portoferraio al capitano Eugenio Massa, raccontò: « Ero acclamato quale novello liberatore. Comitati reazionari con arruolamenti segreti fornivano l’elemento uomo« . In Puglia, per un anno e mezzo Pasquale Romano fu il terrore dell’esercito. Quando venne ucciso in combattimento, il suo corpo fu esposto per una settimana nel suo paese, Gioia del Colle, come monito a eventuali ribelli. Ma erano migliaia gli uomini in armi e migliaia furono i morti di quella guerra non dichiarata.
RIBELLIONE
Una guerra che venne venduta in Europa come problema di delinquenza violenta, per ragioni politico- diplomatiche. Come si poteva ammettere che il Sud Italia, dopo i travolgenti risultati del voto con suffragio universale sull’annessione dell’ex Regno delle Due Sicilie, ora si ribellasse? Con onestà, nel 1861 Massimo D’Azeglio osservò: « A Napoli abbiamo cacciato un sovrano per stabilire un governo sul consenso universale, ma ci vogliono, e pare che non bastino, 60 battaglioni per tenere il regno, ed è notorio che, briganti o non briganti, non tutti ne vogliono sapere. Mi diranno, e il suffragio universale? Io non so niente di suffragio, ma so che di qua del Tronto non ci vogliono 60 battaglioni e di là sì. Dunque, deve essere corso qualche errore« . Il Mezzogiorno divenne il Far West dell’Italia post-unitaria. Le caratteristiche c’erano tutte: inseguimenti con cavalli morti per la fatica, assalti a treni e convogli, scorte militari obbligatorie per assicurare l’incolumità ai parenti dei notabili locali in viaggio. Furono organizzate squadriglie, pagate dai ricchi latifondisti locali, per combattere le bande. Vennero finanziate taglie sui capi. I soldati caduti venivano evirati, ai briganti invece si tagliava la testa, da esibire come monito.
TERRA BRUCIATA
Quella guerra spietata fu condotta con durezza dalla neonata Italia: nel Mezzogiorno arrivarono 120mila soldati impegnati nella repressione. Militari, carabinieri, uomini della Guardia nazionale italiana istituita appositamente applicarono la tattica della terra bruciata attorno alle bande, mentre i briganti adottarono tecniche da guerriglia. Furono costituite due commissioni d’inchiesta parlamentari e poi, dopo più dibattiti in aula sulle « province napolitane« , venne approvata la prima legge speciale dell’Italia unita: la Legge Pica (v. riquadro), che sopprimeva le garanzie costituzionali nelle sei regioni meridionali, dove comandavano i tribunali militari, senza garanzie per gli imputati. Furono anche usati gli scatti dei briganti uccisi per la propaganda. Quei volti segnati erano l’immagine dei meridionali che si diffuse nei salotti della buona borghesia al Nord, alimentando pregiudizi. Una brutta eredità culturale per l’Italia unita, cui si unirono/aggiunsero gli studi di antropologia criminale avviati a fine Ottocento da Cesare Lombroso, che sezionò i crani dei briganti e diagnosticò (si fa per dire) una loro « predisposizione alla ribellione e alla violenza« .
« Per distruggere il brigantaggio abbiamo fatto scorrere sangue a fiumi, ma in politica siamo stati buoni chirurghi e pessimi medici« , ammise lo storico Pasquale Villari nel 1878. E in effetti da quegli anni il Mezzogiorno ereditò soprattutto disincanto, estraneità verso uno Stato repressivo, lacerazione sociale. Del resto furono le stesse classi dirigenti dei latifondisti a chiedere più cannoni e truppe: temevano che la rivoluzione politica, approdata a un semplice cambio di dinastia, si trasformasse in rivoluzione sociale. Vinse il famoso gattopardismo (vedi box). E, per centinaia di migliaia di contadini e di meridionali affamati che, come scrisse Molfese, « erano stati posti dinanzi all’alternativa di vivere in ginocchio o di morire in piedi« , si aprì un penoso destino: l’emigrazione nell’America del Sud, negli Stati Uniti, in Svizzera. « L’emigrante sarebbe stato brigante o complice, ora portava la sua forza lavoro, il suo misticismo doloroso nella terra lontana » come scrisse il presidente del Consiglio di allora, Francesco Saverio Nitti. Era la condanna per il Mezzogiorno rurale in un’Italia che abbracciava le idee del capitalismo e della cultura del mercato. Moriva così il mondo contadino. « Dopo il brigantaggio, queste terre hanno ritrovato una loro funebre pace« , commentò Carlo Levi.
G. D. F. e M. L.
UNA LEGGE SOLTANTO PER IL SUD
La Legge Pica è la prima delle tante leggi speciali che, dall’Unità in poi, sono state applicate nel Mezzogiorno. Arrivo dopo un lungo dibattito parlamentare. Alla fine del lavoro delle commissioni d’inchiesta sul brigantaggio. A proporla, il deputato Giuseppe Pica.
Portava il numero 1049 e fu approvata il 15 agosto 1863. Nove articoli, l’istituzione di tribunali militari, con poche garanzie per gli imputati, nelle sei regioni meridionali, dove si combatteva la guerra civile del brigantaggio. E poi l’istituzione di commissioni provinciali per decidere, sulla base di sospetti e segnalazioni, l’invio alle isole di « camorristi ». Fu la prima volta che, nell’Italia unita, in una legge compariva questo termine.
In sostanza, considerando il brigantaggio solo un problema criminale e non anche socio- politico, i delinquenti nel Sud si dividevano in « briganti » nelle campagne e sui monti e “camorristi » in città, specie a Napoli. La Legge Pica fu applicata fino al 1865 e fu estesa anche alla Sicilia.
Giuridicamente l’Italia fu divisa in due: al Centro-Nord valevano le garanzie dello Statuto Albertino mentre nel Sud no. Le esecuzioni sul posto diventarono la regola e, poiché la lege prevedeva che si potevano giustiziare solo i capi e coloro che fuggivano, per giustificare l’alto numero di morti nei rapporti ufficiali si affermò il falso parlando di decine di briganti in fuga uccisi a fucilate.
TRA MAFIA E BRIGANTAGGIO
Mentre infuriava il I brigantaggio, nelle terre del Meridione si andò consolidando anche il fenomeno mafioso, le cui origini rurali derivavano dal complesso rapporto tra latifondisti e potere borbonico. Tale retroterra favori infatti la nascita di associazioni criminali destinate a diventare uno « Stato nello Stato« . Su tutte, la mafia in Sicilia, la ‘ndrangheta in Calabria e la camorra nel Napoletano.
Fin dai primi tempi, furono molti i casi di complicità tra politica e gruppi mafiosi, per ottenere « favori elettorali » e per risolvere questioni in cui lo Stato non riusciva a districarsi. Non è sorprendente la scelta di ricorrere a individui « in odor di mafia » per combattere gli stessi briganti. D’altro canto, il fenomeno mafioso e quello brigantesco erano ben distinti. Se i briganti, organizzati in piccole bande, conducevano infatti un’insurrezione connotata da rivendicazioni politiche e sociali, i mafiosi erano invece strutturati in rigide gerarchie ed erano criminali di professione, con lo scopo di sfruttare il sistema vigente. Qualunque esso fosse.
IL GATTOPARDISMO
Nel linguaggio letterario e giornalistico, con questa parola si vuole mettere in luce l’atteggiamento di colui che avendo fatto parte del ceto dominante o agiato in un precedente regime, si adatta a una nuova situazione politica, sociale o economica, simulando d’esserne promotore o fautore, per poter conservare il proprio potere e i privilegi della propria classe. Il termine, così come la concezione e la prassi che con esso vengono espresse, è fondato sull’affermazione paradossale che “tutto deve cambiare perché tutto resti come prima”, che è l’adattamento più diffuso con cui viene citato il passo che nel romanzo Il Gattopardo dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si legge testualmente in questa forma: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. A pronunciare la frase non è però il principe di Salina ma suo nipote Tancredi.